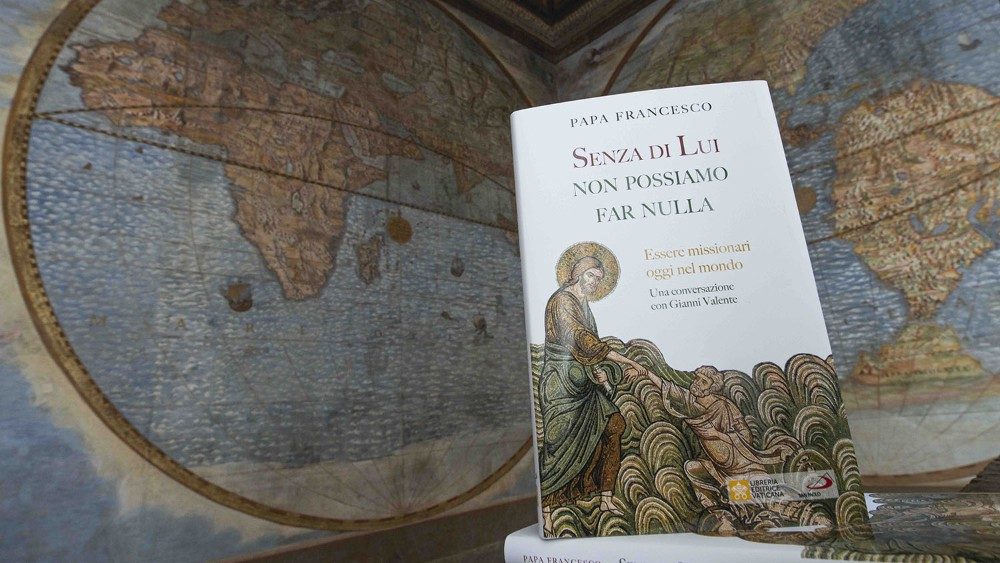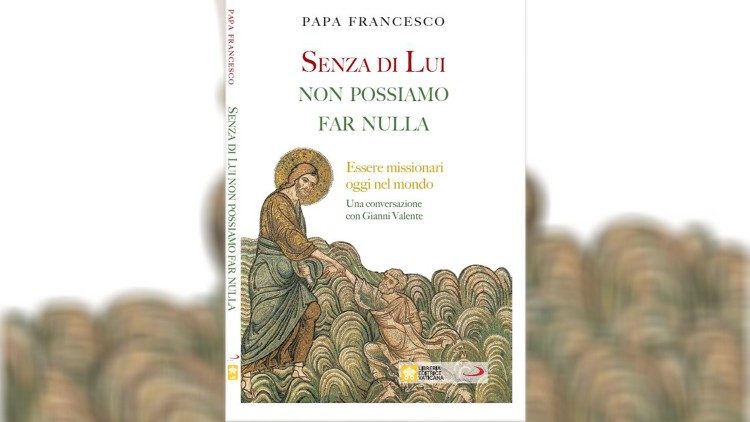Il Papa e la missione: "Senza Gesù non possiamo far nulla"
Gianni Valente
«La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita di coloro che si incontrano con Gesù». Così inizia l’Esortazione apostolica Evangelii gaudium, pubblicata da Papa Francesco nel novembre 2013, otto mesi dopo il Conclave che lo aveva eletto Vescovo di Roma e Successore di Pietro. Quel testo programmatico del pontificato invitava tutti a ri-sintonizzare ogni atto, riflessione e iniziativa ecclesiale «sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale». Quasi sei anni dopo, per l’ottobre 2019 appena concluso, il Pontefice ha indetto il Mese missionario straordinario, e nel contempo ha convocato a Roma l’Assemblea speciale del Sinodo dei vescovi dedicata alla Regione amazzonica, con l’intento di suggerire anche nuovi cammini di annuncio del Vangelo nel “polmone verde”, martoriato dallo sfruttamento predatorio che violenta e infligge ferite «ai nostri fratelli e alla nostra sorella terra» (omelia del Santo Padre per la messa di chiusura del Sinodo per la Regione panamazzonica).
Durante questo arco di tempo, Papa Francesco ha disseminato nel suo magistero riferimenti insistenti alla natura propria della missione della Chiesa nel mondo. Ad esempio, il Pontefice ha ripetuto infinite volte che annunciare il Vangelo non è «proselitismo», e che la Chiesa cresce «per attrazione» e per «testimonianza». Una costellazione di espressioni tutte orientate a suggerire per accenni qual è il dinamismo proprio di ogni opera apostolica, e quale può essere la sua sorgente.
Di tutto questo, e di molto altro, Papa Francesco parla nel libro-intervista intitolato "Senza di Lui non possiamo far nulla. Una conversazione sull’essere missionari oggi nel mondo". L’Agenzia Fides ne propone in anteprima alcuni estratti.
Lei ha raccontato che da giovane voleva andare missionario in Giappone. Si può dire che il Papa è un missionario mancato?
Non lo so. Sono entrato nei gesuiti perché mi colpiva la loro vocazione missionaria, il loro andare sempre verso le frontiere. Allora non sono potuto andare in Giappone. Ma ho sempre avvertito che annunciare Gesù e il suo Vangelo comporta sempre un certo uscire e mettersi in cammino.
Lei ripete sempre: “Chiesa in uscita”. L’espressione viene rilanciata da tanti, e a volte sembra diventato uno slogan abusato, a disposizione di quelli, sempre più numerosi, che passano il tempo a dar lezioni alla Chiesa su come dovrebbe o non dovrebbe essere.
“Chiesa in uscita” non è una espressione alla moda che mi sono inventato io. È il comando di Gesù, che nel Vangelo di Marco chiede ai suoi di andare in tutto il mondo e predicare il Vangelo «a ogni creatura». La Chiesa o è in uscita o non è Chiesa. O è in annuncio o non è Chiesa. Se la Chiesa non esce si corrompe, si snatura. Diventa un’altra cosa.
Che cosa diventa una Chiesa che non annuncia e non esce?
Diventa un’associazione spirituale. Una multinazionale per lanciare iniziative e messaggi di contenuto etico-religioso. Niente di male, ma non è la Chiesa. Questo è un rischio di qualsiasi organizzazione statica nella Chiesa. Si finisce per addomesticare Cristo. Non dai più testimonianza di ciò che opera Cristo, ma parli a nome di una certa idea di Cristo. Un’idea posseduta e addomesticata da te. Organizzi tu le cose, diventi il piccolo impresario della vita ecclesiale, dove tutto avviene secondo programma stabilito, e cioè solo da seguire secondo le istruzioni. Ma non riaccade mai l’incontro con Cristo. Non riaccade più l’incontro che ti aveva toccato il cuore all’inizio.
La missione è di per sé antidoto a tutto questo? Basta la volontà e lo sforzo di “uscire” in missione per evitare queste distorsioni?
La missione, la “Chiesa in uscita”, non sono un programma, una intenzione da realizzare per sforzo di volontà. È Cristo che fa uscire la Chiesa da se stessa. Nella missione di annunciare il Vangelo, tu ti muovi perché lo Spirito Santo ti spinge, e ti porta. E quando tu arrivi, ti accorgi che Lui è arrivato prima di te, e ti sta aspettando. Lo Spirito del Signore è arrivato prima. Lui previene, anche per prepararti il cammino, ed è già all’opera.
In un incontro con le Pontificie opere missionarie, Lei ha suggerito loro di leggere gli Atti degli Apostoli, come testo abituale di preghiera. Il racconto degli inizi, e non un manuale di strategia missionaria “moderno”. Come mai?
Il protagonista degli Atti degli Apostoli non sono gli apostoli. Il protagonista è lo Spirito Santo. Gli Apostoli lo riconoscono e lo attestano per primi. Quando comunicano ai fratelli di Antiochia le indicazioni stabilite al Concilio di Gerusalemme, scrivono: «Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi». Loro riconoscevano con realismo in fatto che era il Signore ad aggiungere ogni giorno alla comunità «quelli che erano salvati», e non gli sforzi di persuasione degli uomini.
E adesso è come allora? Non è cambiato niente?
L’esperienza degli apostoli è come un paradigma che vale per sempre. Basta pensare a come le cose negli Atti degli apostoli avvengono gratuitamente, senza forzature. È una vicenda, una storia di uomini in cui i discepoli arrivano sempre secondi, arrivano sempre dopo lo Spirito Santo che agisce. Lui prepara e lavora i cuori. Scombussola i loro piani. È lui a accompagnarli, guidarli e consolarli dentro tutte le circostanze che si trovano a vivere. Quando arrivano i problemi e le persecuzioni, lo Spirito Santo lavora anche lì, in maniera ancora più sorprendente, con il suo conforto, le sue consolazioni. Come avviene dopo il primo martirio, quello di Santo Stefano.
Che cosa avviene?
Inizia un tempo di persecuzione, e tanti discepoli fuggono da Gerusalemme, vanno nella Giudea e nella Samaria. E lì, mentre sono sparpagliati e fuggitivi, cominciano a annunciare il Vangelo, anche se sono soli e con loro non ci sono gli Apostoli, rimasti a Gerusalemme. Sono battezzati, e lo Spirito santo dà loro il coraggio apostolico. Lì si vede per la prima volta che il battesimo è sufficiente per diventare annunciatori del Vangelo. La missione è quella cosa lì. La missione è opera Sua. È inutile agitarsi. Non serve organizzare noi, non serve urlare. Non servono trovate o stratagemmi. Serve solo chiedere di poter rifare oggi l’esperienza che ti fa dire «abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi».
E se non c’è questa esperienza, che senso hanno le chiamate alla mobilitazione missionaria?
Senza lo Spirito, voler fare la missione diventa un’altra cosa. Diventa, direi, un progetto di conquista, la pretesa di una conquista che realizziamo noi. Una conquista religiosa, o forse ideologica, magari fatta anche con buone intenzioni. Ma è un’altra cosa.
Citando Papa Benedetto XVI, Lei ripete spesso che la Chiesa cresce per attrazione. Cosa intende indicare? Chi attrae? Chi viene attirato?
Lo dice Gesù nel Vangelo di Giovanni. «Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». E nello stesso Vangelo, dice anche: «Nessuno viene a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato». La Chiesa ha sempre riconosciuto che questa è la forma propria di ogni moto che avvicina a Gesù e al Vangelo. Non una convinzione, un ragionamento, una presa di coscienza. Non una pressione, o una costrizione. Si tratta sempre di una attrazione. Già il Profeta Geremia dice «tu mi hai sedotto, e io mi sono lasciato sedurre». E questo vale per gli stessi apostoli, per gli stessi missionari, e per la loro opera.
In che modo avviene quanto Lei ha appena descritto?
Il mandato del Signore di uscire e annunciare il vangelo preme da dentro, per innamoramento, per attrazione amorosa. Non si segue Cristo e tanto meno si diventa annunciatori di lui e del suo Vangelo per una decisione presa a tavolino, per un attivismo autoindotto. Anche lo slancio missionario può essere fecondo solo se avviene dentro questa attrazione, e la trasmette agli altri.
Qual è il significato di queste parole rispetto alla missione e all’annuncio del Vangelo?
Vuol dire che se a attirarti è Cristo, se ti muovi e fai le cose perché sei attirato da Cristo, gli altri se ne accorgono senza sforzo. Non c’è bi- sogno di dimostrarlo, e tanto meno di ostentarlo. Invece, chi pensa di fare il protagonista o l’impresario della missione, con tutti i suoi buoni propositi e le sue dichiarazioni d’intenti spesso finisce per attirare nessuno.
Lei, nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium, riconosce che tutto questo può «procurarci una certa vertigine». Come quella di chi si immerge in un mare dove non sa cosa incontrerà. Che cosa voleva suggerire con questa immagine? Queste parole riguardano anche la missione?
La missione non è un progetto aziendale ben collaudato. Non è nemmeno uno spettacolo organizzato per contare quanta gente vi prende parte grazie alle nostre propagande. Lo Spirito Santo opera come vuole, quando vuole e dove vuole. E questo può comportare una certa vertigine. Eppure il vertice della libertà riposa proprio in questo lasciarsi portare dallo Spirito, rinunciando a calcolare e a controllare tutto. E proprio in questo imitiamo Cristo stesso, che nel mistero della sua Resurrezione ha imparato a riposare nella tenerezza delle braccia del Padre. La misteriosa fecondità della missione non consiste nelle nostre intenzioni, nei nostri metodi, nei nostri slanci e nelle nostre iniziative, ma riposa proprio in questa vertigine: la vertigine che si avverte davanti alle parole di Gesù, quando dice «senza di me non potete far nulla».
Lei ama ripetere anche che la Chiesa cresce «per testimonianza». Quale suggerimento sta cercando di dare con questa sua insistenza?
Il fatto che l’attrazione si fa testimonianza in noi. Il testimone attesta ciò che l’opera di Cristo e del suo Spirito hanno compiuto realmente nella sua vita. Dopo la Resurrezione, è Cristo stesso che si rende visibile agli apostoli. È lui che fa di loro dei testimoni. Anche la testimonianza non è una propria prestazione, si è testimoni delle opere del Signore.
Altra cosa che Lei ripete spesso, in questo caso in chiave negativa: la Chiesa non cresce per proselitismo e la missione della Chiesa non è proselitismo. Come mai tanta insistenza? È per custodire i buoni rapporti con le altre Chiese e il dialogo con le tradizioni religiose?
Il problema con il proselitismo non è solo il fatto che contraddice il cammino ecumenico e il dialogo interreligioso. C’è proselitismo dovunque c’è l’idea di far crescere la Chiesa facendo a meno dell’attrazione di Cristo e dell’opera dello Spirito, puntando tutto su un qualsiasi tipo di “discorso sapiente”. Quindi, come prima cosa, il proselitismo taglia fuori dalla missione Cristo stesso, e lo Spirito Santo, anche quando pretende di parlare e agire in nome di Cristo, in maniera nominalistica. Il proselitismo è sempre violento per sua natura, anche quando la dissimula o la esercita con i guanti. Non sopporta la libertà e la gratuità con cui la fede può trasmettersi, per grazia, da persona a persona. Per questo il proselitismo non è solo quello del passato, dei tempi dell’antico colonialismo, o delle conversioni forzate o comprate con la promessa di vantaggi materiali. Ci può essere proselitismo anche oggi, anche nelle parrocchie, nelle comunità, nei movimenti, nelle congregazioni religiose.
E allora, cosa vuol dire annunciare il Vangelo?
L’annuncio del Vangelo vuol dire consegnare in parole sobrie e precise la testimonianza stessa di Cristo, come fecero gli apostoli. Ma non serve inventare discorsi persuasivi. L’annuncio del Vangelo può essere anche sussurrato, ma passa sempre attraverso la forza sconvolgente dello scandalo della croce. E segue da sempre la via indicata nella lettera di San Pietro apostolo, che consiste nel semplice «dare ragione» agli altri della propria speranza. Una speranza che rimane scandalo e stoltezza agli occhi del mondo.
Da cosa si riconosce il “missionare” cristiano?
Un tratto distintivo è quello di fare da facilitatori, e non da controllori della fede. Facilitare, rendere facile, non porre noi ostacoli al desiderio di Gesù di abbracciare tutti, di guarire tutti, di salvare tutti. Non fare selezioni, non fare “dogane pastorali”. Non fare la parte di quelli che si mettono sulla porta a controllare se gli altri hanno i requisiti per entrare. Ricordo i parroci e le comunità che a Buenos Aires avevano messo in campo tante iniziative per rendere più facile l’accesso al battesimo. Si erano accorti che negli ultimi anni stava crescendo il numero di quelli che non venivano battezzati per tanti motivi, anche sociologici, e volevano ricordare a tutti che essere battezzati è una cosa semplice, che tutti lo possono chiedere, per sé e per i propri figli. La strada presa da quei parroci e da quelle comunità era una sola: non aggiungere pesi, non accampare pretese, togliere di mezzo ogni difficoltà di carattere culturale, psicologico o pratico che poteva spingere le persone a rinviare o lasciar cadere l’intenzione di battezzare i propri figli.
In America, all’inizio dell’evangelizzazione, i missionari discutevano su chi fosse “degno” di ricevere il battesimo. Come andarono a finire quelle dispute?
Papa Paolo III rifiutò le teorie di chi sosteneva che gli indios erano per natura “incapaci” di accogliere il Vangelo e confermò la scelta di chi facilitava il loro battesimo. Sembrano cose passate, eppure anche adesso ci sono circoli e settori che si presentano come “ilustrados”, illuminati, e sequestrano anche l’annuncio del Vangelo nelle loro logiche distorte che dividono il mondo tra “civiltà” e “barbarie”. L’idea che il Signore abbia tra i suoi prediletti anche tante “cabecitas negras” li irrita, li mette di cattivo umore. Considerano buona parte della famiglia umana come se fosse un’entità di classe inferiore, inadatta a raggiungere secondo i loro standard i livelli decenti nella vita spirituale e intellettuale. Su questa base può svilupparsi un disprezzo per i popoli considerati di secondo livello. Tutto questo è emerso anche in occasione del Sinodo dei vescovi sull’Amazzonia.
In diversi tendono a porre in alternativa dialettica l’annuncio chiaro della fede e le opere sociali. Dicono che non bisogna ridurre la missione al sostegno alle opere sociali. È una preoccupazione legittima?
Tutto quello che è dentro l’orizzonte delle Beatitudini e delle opere di misericordia va d’accordo con la missione, è già annuncio, è già missione. La Chiesa non è una Ong, la Chiesa è un’altra cosa. Ma la Chiesa è anche un ospedale da campo, dove si accolgono tutti, così come sono, si curano le ferite di tutti. E questo fa parte della sua missione. Tutto dipende dall’amore che muove il cuore di chi fa le cose. Se un missionario aiuta a scavare un pozzo in Mozambico, perché si è accorto che serve a quelli che lui battezza e a cui predica il Vangelo, come si fa a dire che quell’opera è separata dall’annuncio?
Quali sono oggi le nuove attenzioni e sensibilità da esercitare nei processi volti a rendere fecondo l’annuncio del vangelo nei diversi contesti sociali e culturali?
Il cristianesimo non dispone di un unico modello culturale. Come ha riconosciuto Giovanni Paolo II, «restando pienamente se stesso, nella totale fedeltà all’annuncio evangelico e alla tradizione ecclesiale, il cristianesimo porterà anche il volto delle tante culture e dei tanti popoli in cui è accolto e radicato». Lo Spirito Santo abbellisce la Chiesa, con le espressioni nuove delle persone e delle comunità che abbracciano il Vangelo. Così la Chiesa, assumendo i valori delle differenti culture, diventa “sponsa ornata monilibus suis”, “la sposa che si adorna con i suoi gioielli”, di cui parla il Profeta Isaia. E vero che alcune culture sono state strettamente legate alla predicazione del Vangelo e allo sviluppo di un pensiero cristiano. Ma nel tempo che stiamo vivendo, diventa ancora più urgente tener presente che il messaggio rivelato non si identifica con nessuna cultura. E nell’incontro con nuove culture o con culture che non hanno accolto la predicazione cristiana, non bisogna provare a imporre una determinata forma culturale insieme con la proposta evangelica. Oggi anche nell’opera missionaria conviene ancor di più non portare bagagli pesanti.
Missione e martirio. Lei ha richiamato spesso il vincolo intimo che unisce queste due esperienze.
Nella vita cristiana l’esperienza del martirio e la proclamazione del Vangelo a tutti hanno la stessa origine, la stessa sorgente, quando l’amore di Dio effuso nei nostri cuori dallo Spirito Santo dona forza, coraggio e consolazione. Il martirio è la massima espressione del riconoscimento e della testimonianza resa a Cristo, che rappresentano il compimento della missione, dell’opera apostolica. Penso sempre ai fratelli copti trucidati in Libia, che pronunciavano sottovoce il nome di Gesù mentre venivano decapitati. Penso alle suore di Santa Madre Teresa uccise in Yemen, mentre accudivano i pazienti musulmani di una residenza di anziani disabili. Quando le hanno uccise, avevano i grembiuli di lavoro indossati sopra il loro abito religioso. Sono tutti dei vincitori, non delle “vittime”. E il loro martirio, fino allo spargimento di sangue, illumina il martirio che tutti possono patire nella vita di ogni giorno, con la testimonianza resa a Cristo ogni giorno. Quello che si può vedere quando si va a visitare le case di riposo dei vecchi missionari, spesso malridotti dalla vita che hanno fatto. Un missionario mi ha detto che molti di loro perdono la memoria e non ricordano più niente del bene che hanno fatto. «Ma non ha importanza» mi diceva «perché invece questo il Signore lo ricorda molto bene».
Ultimo aggiornamento 06.10.2020
Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui